Nel 1948 il critico d’arte americano Clement Greenberg pubblicò un saggio che analizzava le pratiche dall’Impressionismo all’Espressionismo astratto, focalizzando l’attenzione sulla produzione di Jackson Pollock, le cui opere traevano origine da una stretta maglia di gesti ripetuti su una tela srotolata a terra. Relativamente alle scelte radicali fatte da questo artista, Greenberg affermò come “il futuro della pittura da cavalletto in quanto veicolo di arte ambiziosa è divenuto problematico.”[1]
Per intendersi, lo scritto era rappresentativo di quanto alla pittura da cavalletto andava sostituendosi la pittura “allover” decentrata e polifonica, in grado di svelare l’impermeabilità della superficie, che consentiva allo spettatore una fruizione come fatto osservabile. Di fronte a una simile visione, in cui la pittura abbandona i normali metodi rappresentativi, aveva espresso la sua opinione anche uno dei maggiori esponenti del muralismo messicano, David Alfaro Siqueiros, il quale nel 1924 pubblicò un manifesto in cui gridava alla comunità: “ripudiamo la cosiddetta pittura da cavalletto […] elogiamo l’arte monumentale in tutte le sue forme, perché è di pubblica utilità.”[2]
L’essenza dei passaggi storici sopra citati può essere ripresa in considerazione alla luce del progetto Sol Indiges, organizzato dal Comune di Pomezia in collaborazione con la Fondazione Pastificio Cerere e curato da Marcello Smarrelli con gli artisti Agostino Iacurci (1986, Foggia) e Ivan Tresoldi (1981, Milano), in arte ivan. Sul perché la scelta sia ricaduta su questi artisti, il curatore afferma “sono tra le personalità più interessanti in questo ambito e lo hanno dimostrato attraverso innumerevoli interventi artistici particolarmente significativi, realizzati nello spazio pubblico in diverse parti del mondo”. Sol Indiges è un piano di riqualificazione urbana fondato sulla pratica artistica del murales e coinvolge tre architetture della città di Pomezia: la Biblioteca comunale Ugo Tognazzi per Agostino Iacurci, inaugurata il 9 di aprile, e le scuole Orazio e Publio Virgilio Marone, i cui murales verranno sviluppati da ivan nel mese di ottobre 2021.
Pomezia è una città giovane, sorta dalle paludose terre dell’Agro Pontino Romano bonificate intorno agli anni Trenta del Novecento e iniziò a prendere forma con un piano regolatore firmato da architetti razionalisti. Tuttavia, su questo centro incombe un’ombra antica: nel testo virgiliano dell’Eneide, Sol Indiges è il nome del santuario dedicato al dio Sole, sorto nel luogo dello sbarco di Enea alla foce del Numico, situato nelle campagne limitrofe della città. Ecco che il progetto curato da Marcello Smarrelli coglie tutte queste citazioni, commemorando la storia di un territorio congiuntamente alle fonti letterarie care all’identità nazionale.
È Smarrelli stesso a chiarirlo con queste parole: “il punto di partenza è Enea e la nascita di Roma, attraverso la narrazione di Virgilio, ma vogliamo anche sottolineare l’importanza che l’Eneide ha avuto nella genesi della Divina Commedia in questo 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta”. L’esperienza di riqualificazione urbana curata da Smarrelli ha preso forma sui luoghi architettonici della città deputati a custodire quei valori culturali; così le opere di Iacurci e ivan si presentano come tratti identitari di un capitale sociale volti a vivificare la trasmissione delle risorse cognitive e intellettuali di un’intera comunità. Proprio Smarrelli spiega come: “grazie all’uso di un linguaggio immediato e coinvolgente, le opere di Iacurci e ivan comunicano in maniera trasversale, raggiungendo direttamente pubblici diversi ed eterogenei. Ma, come qualsiasi intervento artistico rivolto allo spazio pubblico, queste azioni devono necessariamente basarsi sul dialogo tra autori, cittadini, istituzioni, committenti, per diventare bene culturale condiviso e identitario”.
L’opera murale di Agostino Iacurci, intitolata Antiporta, si sviluppa sulla superficie della biblioteca comunale Tognazzi con riferimenti iconografici al libro VI dell’Eneide, dove in un antro dalle cento porte si svolge l’incontro tra Enea e la Sibilla Cumana che predirà all’eroe lo sbarco sul litorale laziale. La feracità artistica di Iacurci ha concepito un’opera muraria organizzata secondo uno schematismo figurativo basato sul segno geometrico e su complessi rimandi iconografici. I rami d’oro, le figure di ancelle e i profili di naves romane sono a tal ragione tutte realtà storiche reinterpretate. La distanza aiuta la visibilità complessiva dell’opera, la piattezza bidimensionale ci stimola a immaginare i volumi, così ciò che vediamo ieraticamente è solo un invito a intuire le forme mosse da un ritmo.
Questa abbondanza interpretativa deriva dalla relazione di Iacurci con la fonte letteraria, con la quale afferma di essersi “rapportato in maniera molto libera. È sempre interessante rileggere nella sua interezza un classico che si conosce solo in forma di parafrasi e pillole dai tempi della scuola, con occhi nuovi.” È lo stesso Iacurci a dichiarare di essersi concertato “sugli aspetti magici del poema e sul tema del viaggio”, utilizzando come supporto secondario al testo virgiliano, il volume “Enea, lo straniero: le origini di Roma” di Giulio Guidorizzo (2020). Presentandosi come una pittografia contemporanea, le immagini che sbocciano sull’architettura procedono secondo un equilibrio compositivo caro alla pittura classica, soprattutto ellenica, cosicché le figure di Iacurci si svelano per il carattere esteriore, epiteliale, caratterizzato da una manipolazione delle forme prismatiche e cilindriche, da cui hanno origine i moduli che ci conducono un’intuizione basica.
È una ricchezza percettiva quella di Iacurci che, a parità di richiesta, ci spinge a vedere le cose secondo una prospettiva segnata da una purezza espressiva dallo stile naif. Nel già citato testo di Greenberg, Crisi della pittura di cavalletto, il critico americano coniò una serie di termini che furono utilizzati per la descrizione della pittura americana del dopoguerra. Non appare temerario utilizzare questi stessi termini per la decorazione di Iacurci: colorfield, nell’intenzione essere un’opera che si espande oltre il classico piano della pittura di cavalletto e allover, ispirata da regole geometriche uniformi basate sulla bidimensionalità e frontalità. Guardando l’excursus espositivo di Iacurci rimane fondamentale il suo rapporto con l’antico, laddove lo stesso afferma che questa indagine è nata dopo aver visitato la mostra “Gods in colors”, presso Città del Messico, nel cui contesto “venivano presentati i risultati di anni di ricerca dell’archeologo Vinzenz Brinkmann attraverso ricostruzioni in scala reale di statue antiche greche e romane secondo le colorazioni originali”.
Questo incontro potrebbe aver influenzato l’uso di Iacurci del colore? Sembra di sì, considerando quanto una tale scoperta abbia fatto riflettere l’artista “sulla potenza e le implicazioni di alcuni dati che diamo per scontati, come appunto il candore della statuaria antica, con tutte le implicazioni politiche e culturali che ne derivano” sino a condurlo a un approfondimento dei “classici come Vitruvio e Virgilio”.
Relativamente al secondo intervento che si svilupperà nell’autunno del 2021, l’artista ivan tiene a precisare che sarà “un’opera d’arte pubblica e partecipata che abbraccia tutte le dimensioni della socialità e della cultura, amplificandosi e rafforzandosi, nella performance, nell’happening, nel neomuralismo, nel sapere condiviso, nella progettazione e rigenerazione urbana, nella poesia di strada e nell’assalto poetico”. Nell’intento di voler creare un valore condiviso per la comunità, il titolo del progetto è esplicativo: Chiamata Alle Arti-Fare Scuola. Un’opera murale, in altri termini, nata dal desiderio di voler “dare la parola” a quei territori attraverso la pratica murale, che ivan definisce come “un monologo sulla poesia e il valore delle parole”, in modo da presentarsi come una “nuova ecologia sociale, che strutturi nei partecipanti processi positivi di relazione solidale tra loro e l’intorno territoriale di riferimento”.
L’insieme esplicitato si pone, dunque, come una questione molto interessante per l’arte contemporanea giacché induce l’interrogativo se esista una propria specificità, una sorta di plusvalore, o se, invece, gli spazi si rivelano semplicemente dati gli scopi. La risposta più logica è proprio nello strumento artistico in quanto tale, nel plusvalore che lo caratterizza!
Maria Vittoria Pinotti
[1] Clement Greenberg, La crisi della pittura di cavalletto (1948), in Il luogo dell’arte oggi, Jaca Book, Milano, 1988, p.134
[2] Hal Foster, Rosalind Krauss, Il muralismo messicano, in Arte dal Novecento, Zanichelli, Milano, 2017, p.280
 Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
 Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
 Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
 Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
Agostino Iacurci, L’antiporta, 2021, superficie interessata dall’intervento circa 1000 mq, Biblioteca comunale Ugo Tognazzi a Pomezia, Ph. Credit Andrea Pizzalis, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
 Agostino Iacurci, a lavoro, Ph. Credit Riccardo Roberti, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
Agostino Iacurci, a lavoro, Ph. Credit Riccardo Roberti, Courtesy Fondazione Pastificio Cerere
 ivan, La pagina e la grande poesia nascosta, performance, Milano, 2016
ivan, La pagina e la grande poesia nascosta, performance, Milano, 2016

Maria Vittoria Pinotti (1986, San Benedetto del Tronto) è storica dell’arte, autrice e critica indipendente. Attualmente è coordinatrice dell’Archivio fotografico di Claudio Abate e Manager presso lo Studio di Elena Bellantoni. Dal 2016 al 2023 ha rivestito il ruolo di Gallery Manager in una galleria nel centro storico di Roma. Ha lavorato con uffici ministeriali, quali il Segretariato Generale del Ministero della Cultura e l’Archivio Centrale dello Stato. Attualmente collabora con riviste del settore culturale concentrandosi su approfondimenti tematici dedicati all’arte moderna e contemporanea.


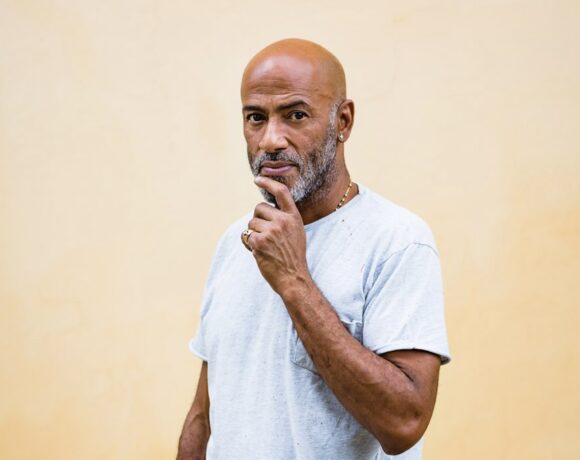



NO COMMENT